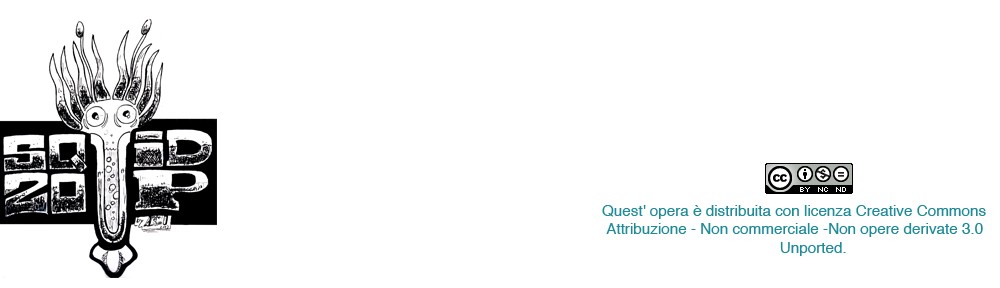I GRAFICI PRECISI DELL’IMPONDERABILE, LE PREVISIONI DETTAGLIATE DELL’IMPREVEDIBILE
Tra i tanti fenomeni interessanti che in questi giorni stanno verificandosi, ve ne è uno un po’ sottotraccia che però trovo particolarmente adatto per dare il via a un chiacchiericcio sommesso e domenicale, che non disturbi chi ancora sta dormendo.
Lo vedo così perché mi sento chiamato in causa nella veste di potenziale imputato – qui si fa il processo a quelle che erano anche mie intenzioni – e in quella di spettatore ammesso all’aula di tribunale nella quale, con le porte chiuse, si svolge il dibattito processuale.
In reatà, le porte sono rimaste spalancate, ma è come se fossero ben serrate e piantonate da due gendarmi per la solita scelta della rete di ignorare alcuni dibattimenti, almeno fintanto che la discussione mantiene il suo carattere decisamente tecnico.
Si tengono tutti a distanza, in attesa di vedere se da quell’aula uscira un “sì” o un “no”, un 1 o uno 0, un giudizio netto, insomma, e che non richieda troppo impengo interpretativo.
Solo così, infatti, tutti, anche i laureati nei due atenei più importanti, quello della vita e quello della strada, potranno poi precipitarsi a scrivere sui loro profili cose del tipo: “l’ho sempre detto che di quelli lì non c’era da fidarsi!”, “sono tutti stipendiati da Sòros” e altre minkjate di questo tenore di cui la rete pare non essere mai sazia.
Ma veniamo al fenomeno.
Come ho letto in due articoli molto interessanti, qualcuno alla fine ha reagito a quel tentativo non richiesto di “dare una mano” all’interpretazione dei dati offerto da fisici e, soprattutto, astrofisici.
Nell’erba alta delle discussioni sui social circa la diffusione del contagio, negli ultimi giorni si è osservata di tanto in tanto una strana florescenza di grafici smongoli che interpolano i numeri di morti, ricoverati e guariti forniti da regioni e nazioni e pare che in alcune bolle facebookiane il fenomeno sia così intenso da meritare addirittura l’appellativo di Epidemia di epidemiologia da poltrona.
Vestendo la sicumera che regala l’assunzione grautita del valore delle costanti di integrazione, elevandosi più dell’esponente da dare a un numero di Nepero, un’intera gerarchia di ricercatori si sono lanciati nella valutazione delle impennate delle cifre dei contagi o del loro tentennare che disegna un accidentato plateau.
Questo li ha portati a soccombere all’emergenza espressiva e, senza dirlo davvero (in quei post si lascia spesso fare al motto chi ha orecchie per intendere, intenda), hanno espresso cosa secondo loro accadrà.
Piuttosto che essere sempre e soltanto il trastullo innocente e social di fisici e astrofisici cresciuti a pane e dati, in alcuni casi il frutto di simili passatempi ha avuto spazio sulle pagine di giornali a grande diffusione, dimostrando così di riuscire a polarizzare il comportamento di intere fette di popolazione, convincendole quando dell’inesistenza di un pericolo realmente incombente, quando di qualcosa di ancora più tremendo di ciò che stiamo vivendo.
Intanto questa storia pare abbia avuto la capacità di fare emergere un dato di sicuro interessante: la gente sembra ancora farsi influenzare più dai giornali che dal gossip assordante dei social. Non so per quanto durerà ancora questa situazione per cui, finchcé la cosa funziona, direi di godercela, no?
Senza prendermela qui con quanti hanno avuto la possibilità di amplificare la visibilità dei loro sudoku evoluti tramite la loro pubblicazione su canali comunicativi decisamente sproporzionati rispetto alle loro (nostre) competenze in materia di diffusione delle epidemie, qui mi soffermerei sul tentativo di tratteggiare l’identikit del generatore medio da social di quei grafici.
Si tratta, come un altro articolo diceva, di:
fisici abituati, nelle loro attività quotidiane, a pensare razionalmente ai fenomeni. Il loro compito è misurare costanti e parametri senza distorsioni e con la minima incertezza possibile, interpretare i risultati e costruire visioni del mondo che espandano la nostra comprensione dell’universo. In tal modo, sono guidati da principi molto ben consolidati come il metodo scientifico, l’idea di falsificabilità, il rasoio di Occam e in generale il rigore scientifico, in cui le ipotesi non verificate oltre ogni dubbio e in molti modi sono per impostazione predefinita considerate false. E le loro azioni sono modellate dalla certezza implicita che l’autorevolezza della loro parola, parlata o scritta, è il loro unico mezzo per portare il pane sulla loro tavola: quindi sono spaventati oltre ogni misura di rendersi ridicoli sulla carta per sciatteria o errori di valutazione.
Tra l’altro, stiamo parlando di persone molto facilmente identificabili tramite i modelli cui si ispirano e che sono noti finanche a chi vive al di fuori dei loro ambienti lavorativi. Questo è un aspetto che ritengo importante e singolare: qualcosa che accade di sicuro per gli umanisti (avranno tutti almeno un libro di Leopardi o una versione della Divina Commedia) e per alcune categorie di artisti (un pianista classico di sicuro avrà spartiti di Beethoven o di Mozart) ma che, tra tutti scienziati, mi pare di poter dire che sia riservata solo a fisici e astrofisici.
Senza infatti nulla togliere a biologi, chimici, geologi, matematici… è singolare che chiunque possa indovinare, senza tema di sbagliare troppo, quali siano i nomi degli autori di alcuni libri che di sicuro si trovano nelle librerie come la mia.
Questo credo sia uno dei problemi fondamentali (sì, volevo proprio scrivere “problemi”): oltre a crescere intellettualmente nel rispetto di idee fondamentali, esteticamente perfette, rigorose, predittive, …, studiamo subendo il fascino irresistibile di intelligenze fuori dal normale che quelle idee le hanno elaborate.
A elaborarle sono stati personaggi che spesso hanno furbescamente alimentato il loro mito con atteggiamenti a dir poco bislacchi e contingenti, in aperto, apparente contrasto con l’univocità delle loro idee così scarne, essenziali, corrette. Sono stati vere e proprie divinità del pensiero che, pur pretendendo spesso di essere anche simpatici, non possono che risultare estremamente antipatici per come si macchiano del reato di applicazione non meditata di ingiustificata tuttologia.
Molti di loro hanno davvero parlato di tutto, sentendosi autorizzati, nel farlo, dall’avere fornito contributi importanti ad ambiti nei quali è onestamente molto difficile muoversi con la disinvoltura con la quale un danzatore si appropria di un palco o con la quale un pittore riempie di segni non banali una tela bianca.
A tal proposito, giusto per delineare ancora meglio quell’identikit, stamattina mi è tornato in mente un libello che, ahimé, lessi da ragazzo e che oggi mi è costata una certa fatica ritrovare tra i libri di quei famosi scaffali di cui parlavo prima. Si tratta del dialogo tra Primo Levi e Tullio Regge, una lettura che ostenta una realtà dura a digerire: fai incontrare due teste di quel tipo e scoprirai che, specie se vi è Ernesto Ferrero che poi riporterà tutto in una pubblicazione Einaudi, il tenore delle loro chiacchiere più stupide possiede, non solo un’aura, ma anche un livello contenutistico tale da disintegrare il tuo ego, polverizzando la tua persona di fronte al peso di cotanta assennatezza, cultura, leggerezza nel trattare ciò che per altri è grave, pesante.
In particolare, trovo che quel geniaccio di Regge, nella sua ricercata (e forse poco autentica, non so) simpatia, fosse decisamente antipatico, tutto preso com’era dall’ esaltare i suoi hobby così inusuali e nel rimarcare, quando non occupato a parlare velatamente bene di sé, quanto lui fosse interessante per la bellezza intrinseca e il livello culturale delle persone che frequentava. Praticamente non andava mai al bar. Usciva solo per recarsi a congressi e si rilassava analizzando finemente, col suo palato educato, lo spettro di aromi di vini d’annata. Tutto questo ovviamente durante una lettura pomeridiana del Talmud.
Tra l’altro, in un punto del dialogo (praticamente un monolgo con Levi che, stando basso sotto rete, alza la palla per le alte schiacciate di Regge), allo spunto offerto dal chimico-scrittore quando dice:
Spesso la simpatia è un modo per contrabbandare l’incompetenza. L’Italia è piena di gente simpatica che non conosce il suo mestiere. Saper tarare la controparte è un’operazione fondamentale… Pesarla… Immagino che anche tra i fisici ci sono quelli che recitano la parte
il fisico replica:
É facilissimo. Io qualche volta lo faccio per scherzo, mi diverto a posare da competente in campi in cui non assolutamente niente. Ci riesco con una facilità incredibile. Basta iformarsi prima delle parole-chiave. Come fisico sperimenale valgo poco. Una volta mi sono fatto spiegare che cosa bisogna dire a chi costruisce acceleratori. Ci sono un paio di frasi, tune shift, aumentare la corrente di iniezione, la stabilità del campo… Le ho imparate e una volta in una cena le ho tirate fuori, sono andato avanti per venti minuti.
Qui l’autocompiacimento mi sembra talmente tanto intenso da richiedere anche il sacrificio di una autodenuncia e credo vada letto come: “se non so qualcosa, sono così intelligente da poter simulare senza essere scoperto di saperne tantissimo; almeno tanto quanto i più grandi esperti di quel campo” (che, implicitamente, diventa un campo di importanza secondaria rispetto al suo). Per non parlare, poi, della richiesta di essere valutato come persona la quale, nonostante abbia trascorso tutto il suo tempo a ragionare di cose elevatissime, sa anche stare al mondo manifesando la stessa scaltrezza di uno scafatissimo gambler da saloon. Insomma, (per me) insopportabile.
Ho preso questo modello a caso, ma avrei tranquillamente potuto citare altri mille libri dello stesso tenore (con questa frase ho ceduto alla tentazione di farvi sapere che ho letto mille libri, e che la mia biblioteca è molto più ricca della vostra) nei quali viene ostentata la leggerezza di ciò che leggero non è; la facilità di ciò che facile non è.
Il problema non credo stia nell’impossibilità di trovare leggerezza e facilità in cose ritenute definitivamente pesanti e ostiche. Tutt’altro. In quanto vittima anche io di certe letture e certi miti, mi sento investito da tanto del ruolo di eroico paladino del messaggio positivo che vuole qualsiasi argomento affrontabile e godibile da chiunque.
Qui intendo piuttosto denunciare, come ho già pubblicamente fatto in diverse occasioni, l’evidente discrasia nell’atteggiamento usato da alcuni nel dire che una certa cosa dura da digerire è in reatà molto meno dura di quello che sembra, e ciò che con i loro modi esprimono davvero.
Parlo di quel modo di fare tipico di chi, piuttosto che invitarti DAVVERO a scoprirne con lui la relativa facilità di alcuni argomenti, ti sta ancora una volta dicendo che per lui è facile e che se tu, nonostante la sua spiegazione, ancora non riesci a capirli, lui non sa più che fare.” Io, genio, ho fatto di tutto per spiegarteli, ergo, se non ce la fai a seguirmi, è solo un problema della limitatezza del cervello che ti è toccato in sorte”.
Il mestiere di fisico e di astrofisico, oltreché di sicuro interessantissimo, è certamente arduo per la difficoltà stessa dei problemi che ci si prefigge di risolvere. Purtroppo, per quanto ci si sforzi di assomigliare a quei modelli – che, beninteso, è comunque bene che esistano: sono di sicuro portatori di immensa ispirazione – che, nel mentre intuiscono la curvatura dello spaziotempo, si fanno fotografare con la lingua di fuori nel fare boccacce, nella stragrande maggioranza dei casi si scopre di essere degli ottimi professionisti e nulla di più.
Tutto ciò è difficile da digerire, specie sapendo della vecchia previsione di Wharol il quale ha preconizzato che avremmo tutti, anche noi, goduto di un quarto d’ora di notorietà.
Il futuro in cui la previsione del buon Andy doveva avverarsi dovrebbe essere suppergiù il periodo che stiamo vivendo e allora, non avendo ancora (stranamente) ricevuto gli stessi inviti che furono a suo tempo fatti a Regge e Levi, ci si autoinvita sulla rete facendo articoli, post, video (e fin qui la critica è anche per il sottoscritto…) e, purtroppo, grafici di previsione dell’evoluzione dell’epidemia.
Dico purtroppo perché alla fin fine si tratta comunque di un autogoal; della traduzione grafica di un problema dall’evoluzione ancora impredicibile per l’esiguità della documentazione disponibile e per l’impossibilità di demarcare esattamente i confini entro i quali agire.
Una vecchia barzelletta, che fa ridere solo gli addetti ai lavori, metteva di fronte all’evidenza di come per un fisico sia tutto risolvibile se solo si assume che le mucche possano essere approssimate usando delle sfere.
Un esempio che mi permette di scherzare esagerando un po’ nel dire che in questa fase, il problema della diffusione dell’epidemia può forse risultare predicibile mediante un grafico sotto la sola, plausibile assunzione che il malato quadratico medio sia una sfera. Per definizione, mentre rotola nell’ambiente, lui interagisce con i suoi simili toccandoli solo in punto delle loro liscissime superfici: quello è il punto attraverso il quale avverrà il contagio!
In uno dei due articoli, l’autore, pur ammettendo quanto possa essere divertente giocare con i numeri, si chiede se
deve un non epidemiologo attento alla scienza come me cedere all’impulso di pubblicare analisi improvvisate? Se lo facessi, aggiungerei elementi importanti alla discussione o costituirei semplicemente un’altra fonte di disinformazione ammantandomi con un carattere potenzialmente pericoloso di autorità? (traduzione mia)
Gli fa eco l’autore dell’altro articolo il quale esplicitamente invita ad ignorare coloro i quali, resi dai social ancora più autocompiaciuti, mentono nell’apparire esperti capaci di dire, per vie traverse e scorciatoie grafiche, qualcosa di importante circa ciò che non conoscono, offrendo di conseguenza false ipotesi e, nel peggiore dei casi, certezze (…). L’idea avanzata in quell’articolo è che ciò accada perché sui social
ci sentiamo più protetti dalle critiche esterne. O forse la poltrona di casa è troppo comoda rispetto alla sedia della nostra scrivania in ufficio. Inoltre, i social media non sono uno luogo dove avviene la cosiddetta peer review (un processo di revisione delle idee scientifiche operato da colleghi di chi le propone che operano segretamente per conto di riviste specializzate; nota mia), e in una situazione in rapida evoluzione nessuno ci accuserà di analisi dei dati sciatte se ci abbandoniamo a tale attività (Traduzione ancora mia. Sì, modestamente, so anche tradurre).
Quest’ultimo articolo si chiude con il condivisibilissimo e importante invito a salvare il metodo scientifico che dovrebbe valere sempre e comunque, specie per chi lo ha eletto a modo di vivere e di esprimere la propria professionalità.
Non posso che trovarmi d’accordo su queste posizioni le quali fondamentalmente non fanno altro che puntare il dito sulla forte similitudine, non dichiarata, che vi è tra previsioni compiute senza aver mai studiato seriamente, da epidemiologi, cosa davvero sia una epidemia e come si siano manifestate e diffuse quelle del passato, e quelle ottenute maneggiando un mazzo di carte da tarocchi nelle quali si assume essere filtrato, per contatto, il proprio raro talento da streghe chiaramente manifestatosi sin dalla più tenera età in innumerevoli episodi (se non ci credete, chiedete a mia madre/mia zia/la mia vicina/…)
Siamo qui dunque a denunciare astrologi evoluti mascherati da astrofisici? No di sicuro, anche se in questi frangenti assistiamo ad atteggiamenti apparentati con quelli alla lontana. Ci stiamo muovendo in un ambito che con la fisica e l’epidemiologia non ha più nulla a che fare, finendo invece di diritto solo il controllo della sociologia: una disciplina che condivide con l’epidemiologia il bisogno di avere molti più dati a disposizione.
In conclusione, avanzo un’ipotesi di lavoro. Di fronte al vero e proprio diluvio di pareri squinternati reperibili in rete ed espressi negli idiomi più imrobabili, è anche ovvio che chi nella vita fa lo scienziato si esprima, per deformazione professionale, usando elementi propri del suo linguaggio quotidiano e metodi di analisi tipici del suo modo di approcciare i problemi in generale.
Lo fanno il geometra, il pittore, la massaia, il camionista, l’impiegato, … (se fossi martello, vedrei un mondo di chiodi) e lo fa anche lui, il fisico che prova a parlare in rete risultando ad alcuni occhi impacciato, ad altri saccente. In questo coro di notizie e pareri, ne ho visti davvero di assurdi e leggendo, ad esempio, che secondo la newsletter Al Naba (L’annuncio), organo di informazione interna dell’Isis, il coronavirus
è un tormento che Dio può mandare contro chi vuole, e Lui ne ha fatto una benedizione per i credenti. Chiunque stia sulla terra, aspettando che la piaga colpisca, e sapendo che colpirà solo coloro che Dio ha scelto, per lui sarà come la ricompensa di un martire
trovo un peccato decisamente veniale non solo che i fisici e gli astrofisici pubblichino grafici con la delirante pretesa di dire qualcosa di anche solo lontanamente giusto nel superenalotto di ciò che capiterà davvero, ma anche la notizia – che evidentemente proprio non poteva non essere comunicata – della richiesta ufficiale inoltrata dal Papa a un destinatario non meglio identificato di un intervento miracoloso per la fine della pandemia.
Insomma, rimango agnostico, sorrido e giustifico chi, in maniera colta, ma forse in modo un po’ maldesto, fornisce comunque spunti di riflessione, se non medica, almeno sociologica. Mi compiaccio, poi, del fatto che almeno qui da noi si scelga di affidare chiacchiere evolute (non si può certo dire che non lo siano) ai social senza pretenderne la pericolosa pubblicazione sugli organi di stampa più letti dalla popolazione.
In fondo, è da tempo che auspichiamo una crescita della cultura scientifica della società.
Vedere comparire in un social un grafico che comunque richiede, per chi davvero decida di interpretarlo, l’attivazione di processi mentali altrimenti intorpiditi dal profluvio di giudizi tecnici incentrati solo sull’ultima partita della juve, ritengo possa essere proprio qualcosa che spinge in quella direzione.
Pungoliamo pure la rete con dosi omeopatiche di (quasi) scienza antipatica! Chissà, forse qualcosa succederà. Probabilmente si incazzeranno tutti, ma alla fine vorrà dire che avranno notato come sia possibile parlare anche di altro e che per spararla davvero grossa, per dire un certo genere di cazzate, bisogna comunque avere studiato bene e a lungo negli atenei giusti.
SZ