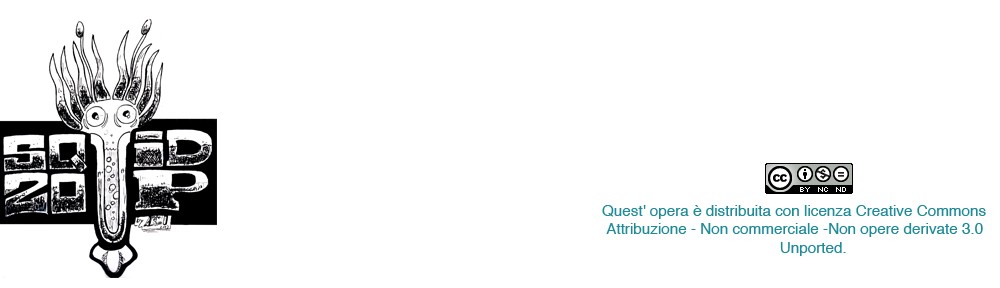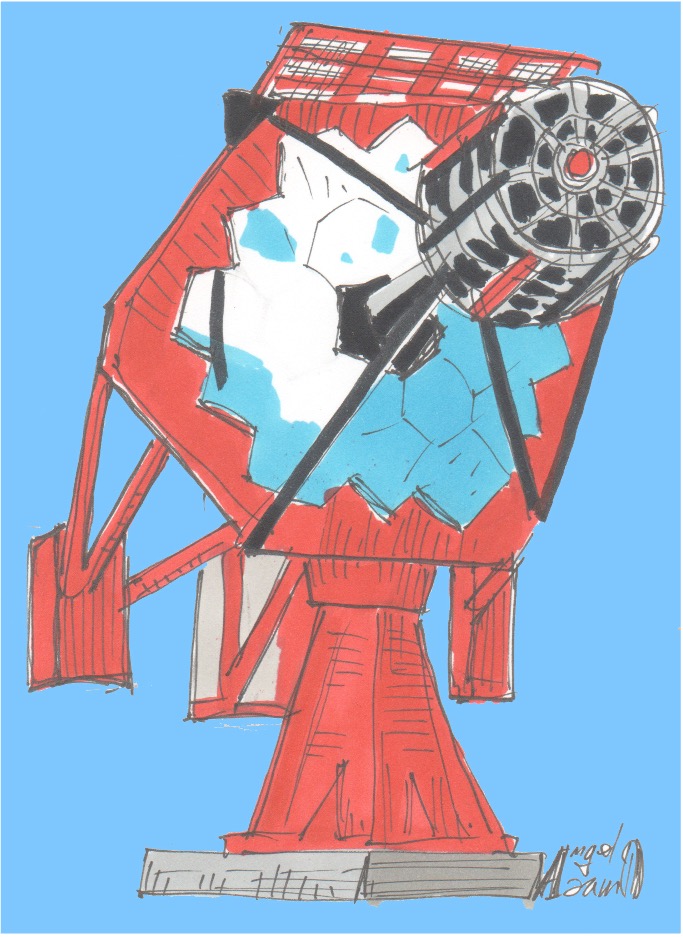Riporto qui per intero un articolo che ho pubblicato ieri sul sito Doctor Harp (https://www.doctorharp.it/) per il quale curo la mia rubrica HarmonicA Mundi
Come è noto, la massima di Plinio Il Vecchio (I secolo d.C.) che leggete nel titolo di questa rubrica è stata estrapolata dalla sua “Storia naturale”. Essa era in origine riferita alla pratica della pittura e viene di solito usata per sottolineare l’importanza dell’impegno costante da profondere in qualsiasi attività umana che lo richieda: lo studio, lo sport, la musica, … Quale modo migliore, quindi, di intitolare una rubrica dedicata allo studio di brani musicali?
A dirla tutta, in un primo momento avevo pensato di parafrasare questa massima così da renderla più sinceramente adatta a ciò che davvero succede nella vita di un musicista il quale, data la situazione attuale dei “lavori culturali”, è probabile si guadagni da vivere non solo con la musica, ma anche con un più che necessario e dignitoso “daily job” che gli consenta di emanciparsi da ansie varie, come anche da proposte musicali non soddisfacenti da un punto di vista professionale.
È proprio ciò che capita al sottoscritto, anche se ho motivi per ritenermi davvero fortunato: il mio lavoro fisso non è un ripiego, bensì la realizzazione, “da grande”, di un’altra mia passione giovanile tanto forte quanto lo è la musica.
Tornando al tentativo di parafrasi che mi ero prefisso di realizzare, non ho potuto fare a meno di notare che il gioco si era nel frattempo fatto comunque interessante: ridimensionare il significato della massima di Plinio così da renderlo, in latino, “pochi giorni senza linea” in luogo di “nessun giorno senza linea”, mi costringeva a pormi domande circa l’uso di quella lingua che non frequentavo da più di trent’anni (37, per essere precisi… Sì, lo so: avrei potuto scrivere “da quasi quarant’anni”, ma non volevo infliggermi troppe frustrazioni).
Complice forse la grande distanza temporale che mi separa da quando, al liceo, tradurre poteva anche essere fonte di stress da prestazione scolastica, confesso che cimentarmi di nuovo con quella lingua mi ha alquanto divertito. Volendo cambiare “nessun giorno” in “pochi giorni”, mi è sembrato in un primo momento naturale porre quel sostantivo all’accusativo, sottintendendo quindi il verbo “trascorrere”.
In pratica, nella mia interpretazione, quella frase doveva essere una sorta di esortazione, se non addirittura un precetto alla stregua di quell’altro famosissimo monito (“Non entri nessuno che non conosca la geometria”) posto all’entrata dell’Accademia di Platone: “Non si trascorra alcun giorno senza aver tracciato una linea (!)”, ma la possibilità che invece si trattasse di una semplice constatazione, quindi della semplice presa di coscienza che per un serio professionista dell’arte della pittura “non trascorre nemmeno un giorno senza aver tracciato una linea”, mi ha portato a rivedere un po’ la faccenda con la lente della grammatica: se “dies” fosse stato neutro, la mia parafrasi avrebbe preso la forma “pauca dies sine linea”, ma dal vocabolario risultava che quel termine può essere sia maschile che femminile (oggi diremmo “fluido”), ma di certo non neutro. Stando così le cose, era chiaro che il “dies” del titolo non è un accusativo, bensì un nominativo; avevo torto e la frase, ahimè!, risultava essere una semplice constatazione.
Una volta… constatatolo, non potevo che rendere la mia parafrasi con “pauci dies sine linea”; roba da far inorridire i puristi (tramite una comune amica, ho contattato un bravo insegnante di lettere esponendogli il problema e, come c’era da attendersi, costui mi ha giustamente invitato a rivalutare la mia intenzione di cambiare quel testo…).
Ecco quindi spiegata la scelta di lasciare come titolo di questa sezione la frase originale di Plinio, seguita da tutta questa spiegazione che, ne sono sicuro, potrebbe meritare di essere a sua volta completata da un “esticazzi!” se non fosse che anche quel giochino linguistico in quel giorno di circa tre settimane fa ha preso il valore di ginnastica mentale, quindi di “linea” tracciata quantomeno per non rimanere col cervello fermo.
Ci sono giorni in cui suono, altri in cui penso alla musica senza emettere una nota; altri ancora in cui leggo, disegno, scrivo, calcolo, ascolto, … Insomma, l’importante è tenere impegnato il “muscolo cerebrale” con diversi tipi di ginnastica, ma non voglio certo farvi temere alcunché: giuro che in questa sezione farò confluire solo quei “gesti mentali” che hanno a che fare con il suonare, e con il farlo usando perlopiù la mia, anzi, la “nostra” armonica.
Eccovi allora, per iniziare questa rubrica, un brano che ho amato molto.
Si tratta del tango in 6/8 El Cacerolazo: un brano che ho scoperto grazie al mio amico Pierpaolo Petta, grande fisarmonicista con il quale mi vanto di condividere più di un progetto musicale, e composto dal fantastico sassofonista Javier Girotto; un tripudio di II-V-I – quasi un Autumn leaves argentino – dalla struttura particolarmente stimolante che, a parte una battuta introduttiva, risulta suddiviso in quattro sezioni, ognuna della durata di 16 misure. Inizia in G-, prosegue poi con una II-V-I nella tonalità di D♭ dalla quale, con una sequenza di accordi a distanza di quarta armonicamente ondivaga e un bridge di altri accordi diminuiti e semidiminuiti, modula in E-. Da lì, poi, in modo molto naturale, arriva alla sezione finale che prevede un ritorno alla stessa tonalità con la quale il brano era iniziato.
É una composizione a mio parere molto triste – il titolo si riferisce a una particolare forma di protesta adottata nei paesi latini dove per fare rumore davanti ai palazzi del potere si usa percuotere pentole e casseruole varie -, ma di una tristezza frenetica; una disperazione capace di togliere il fiato, specie nell’interpretazione suonata a circa 140 bpm dello stesso Girotto accompagnato dal grande Luciano Biondini alla fisarmonica. (Fonte: https://youtu.be/0KYT8-LbE5A?si=GUYBrI8jO2dKe1Wb), una versione dalla quale ho rubato la bellissima idea di usare il pedale di Mi nella sezione in E-.
Come si può evincere dalla visione del mio video nel quale mi sono divertito a improvvisare anche in E- (nella versione originale, per tutta l’impro si rimane nella tonalità di G-), ho registrato il brano fermandomi a 130 bpm perché, pur essendo riuscito a studiarlo fino a portarlo alla stessa velocità del link più su – lo studio con metronomo fa miracoli! – alle volte, nella sezione in D♭, durante i salti di terza minore/maggiore, il trascinamento dello strumento mi faceva “sporcare” la linea melodica col suono di ance intermedie che in quel momento invece avrebbero dovuto tacere.
Un problema che in fase di studio ho in parte risolto 1) suonando tutte quelle note come se sulla testa di ognuna di esse vi fosse segnato il puntino dello “staccato”, e 2) adottando in alcuni passaggi la tecnica del tongue-shifting, ma che ad alte velocità risulta comunque difficile eliminare del tutto.
Bisogna accettarlo: pur essendo convinto che vi siano in giro giovani armonicisti capaci di fare cose fino a poco tempo fa ritenute impossibili, è inevitabile che passaggi particolarmente facili per strumenti sui quali si muovono solo le dita, si rivelino estremamente difficili e scomodi per altri come il nostro sui quali bisogna muovere mani, testa, bocca, magari ragionando pure, a grande velocità, circa quali fori scartare e quali scegliere (senza vederli), in quali soffiare con o senza premere il registro e in quali aspirare con o senza premere il solito registro, …
Studiare questo brano si è comunque rivelata un’ottima occasione per riprendere pure lo studio del pianoforte, quindi dell’armonia: tutte attività che, come il latino, tengono le meningi alquanto occupate.
Insomma, se non ho studiato sullo strumento proprio tutti i giorni, almeno so che lo scorso 12 Dicembre 2023 ho “tracciato la mia linea”. Una linea che oggi rinforzo scrivendo queste righe – quindi non suonando, ma ragionando di musica – e raccontandovi abbastanza nel dettaglio la preparazione del brano che trovate nel video.
Spero che almeno a qualcuno di voi serva da stimolo per prendere la sua matita e riempire di linee, righe e gesti nuovi questa splendida giornata.
SZ